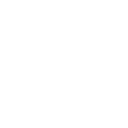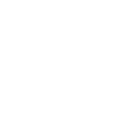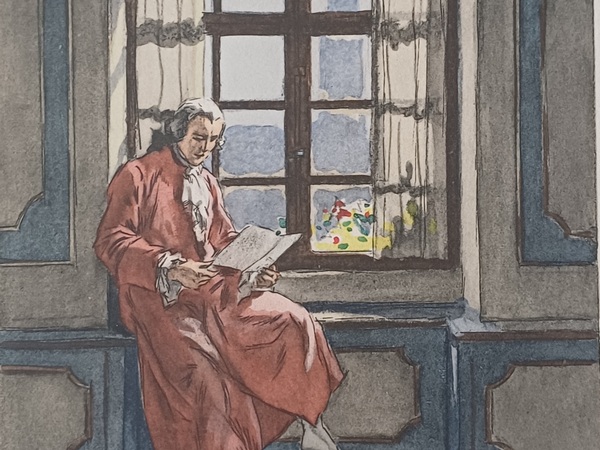Il prof. Sauro Gelichi, che, da pochissimo, ha lasciato l’insegnamento cafoscarino (teneva la Cattedra di Archeologia Medievale dal 1997), ha recentemente ricevuto presso l'Istituto di Archeologia ed Etnologia dell'Accademia delle Scienze di Varsavia la medaglia LUX et LAUS conferitagli dai Medievisti Polacchi per meriti nell’ambito della ricerca storica. Prima di lui lo stesso riconoscimento era stato attribuito a Jaques le Goff.


E’ inoltre stato eletto Socio dell’Accademia dei Lincei, tra le massime istituzioni culturali italiane, durante l’ultima cerimonia di apertura dell’anno accademico.
Lo scorso anno è uscito Le isole del rifugio. Venezia prima di Venezia, un saggio che ha scritto assieme al collega Prof. Stefano Gasparri, dedicato alle fasi iniziali della storia di Venezia. Una sintesi che, dal punto di vista storico-archeologico, tenta di riaggiornare l’agenda della ricerca e riscriverne alcune pagine.
Lo incontriamo per ragionare non solo dei primi secoli della Serenissima, ma anche riflettere sulla sua esperienza di ricercatore in campo archeologico: la disciplina, l’archeologia a Ca’ Foscari, i rapporti con le comunità.
Cominciamo da Venezia. Nella sua esperienza di ricerca archeologia, Venezia e la laguna hanno sempre avuto un ruolo di primo piano. Attraverso i suoi scavi (ricordo che ha diretto ricerche a San Giacomo in Paludo, San Lorenzo di Ammiana, Dogaletto di Mira e Jesolo), lentamente è emersa una realtà lagunare molto più articolata di quanto si poteva immaginare. Come si raccordano tutte queste sue ricerche? Qual è stato, se c’è stato, il filo rosso che accomuna tutti questi luoghi?
Gli scavi nascono spesso dalla casualità e indiscutibilmente alcuni di questi ne sono figli. Diciamo però che non casuali sono stati gli obbiettivi e le finalità che ho cercato di darvi nel corso del tempo. Insegnando a Ca’ Foscari, era quasi naturale che, da medievista, mi occupassi di Venezia (una delle poche città italiane senza un precedente di epoca romana). La letteratura su Venezia è sterminata ma i documenti scritti che parlano delle sue fasi iniziali sono davvero pochi. Anche per questo ho sempre pensato che l'archeologia, con la possibilità che ha di creare e rigenerare continuamente nuove fonti, potesse essere lo strumento più idoneo per approfondire le conoscenze su quei periodi. Nel fare questo, però, bisognava non solo ampliare il numero dei dati a disposizione, ma anche migliorare la qualità degli strumenti teorici e metodologici che si intendevano impiegare. Inoltre, era sempre più evidente come la storia di Venezia non fosse solo la storia di un solo luogo; dunque, non era sufficiente lavorare sulla 'Venezia vincente' - la città che si sviluppò intorno al plesso di Rialto nell’alto medioevo-, ma indagare anche le numerose altre ‘Venezie perdenti’, come Torcello, Metamauco, Cittanova, Equilo. Infine, ho sempre pensato che la storia della Venezia delle origini, mi si passi l’espressione un po’ forte, andasse sprovincializzata e l’archeologia tornasse ad avere una centralità che, fino ad allora, non aveva avuto, se non rapsodicamente. Ma, soprattutto, che si andassero a mettere in discussione (e riformulare) alcuni dei pilastri interpretativi su cui si erano basate (e talvolta ancora si basano) quasi tutte le narrazioni sulla laguna delle origini (la fuga sulle isole, le 'origini selvagge', la bizantinità, l’autoreferenzialità). Questo è dunque quello che ho cercato di fare in tutti questi anni.
Indagare le vestigia del passato attraverso l’archeologia ci può portare a scoprire non solo preziosi manufatti, edifici sepolti, oggetti della vita quotidiana, ma anche i resti degli individui di quelle comunità. È il caso, ad esempio, delle ricerche nel cimitero presso S. Mauro a Jesolo, nel quale la sua équipe ha messo in luce uno dei campioni più numerosi di popolazione presenti in Italia. Cosa ci raccontano esperienze di questo genere?
È vero, gli archeologi spesso dimenticano che hanno una straordinaria opportunità, quella cioè di conoscere direttamente gli individui che hanno popolato un luogo. Dopo alcuni anni, che scavavo a Equilo – uno degli insediamenti altomedievali più importanti della laguna – e nonostante avessimo messo in luce i resti di una mansio (una specie di albergo) del IV secolo d. C. – tra le poche scavate in Italia-, ho pensato che potesse essere molto interessante investigare uno dei cimiteri di quella comunità che si era sviluppato ad Equilo nell’alto medioevo. Così abbiamo scavato un’ampia porzione di necropoli annessa ad una chiesa ed oggi possiamo ricostruire, in maniera più specifica, il profilo biologico e in parte sociale di una comunità lagunare vissuta tra IX e XII secolo: attraverso analisi antropologiche, ma anche isotopiche e genetiche, possiamo conoscere meglio l’andamento demografico, le speranza di vita, le malattie più frequenti (si è scoperto che la nostra era una comunità talassemica), l’alimentazione, la mobilità. Si possono anche indagare comportamenti sociali che si manifestano attraverso la ritualità funeraria (dove e come seppellire), ma anche testare il livello di violenza inter-familiare o il grado di attenzione nei confronti della disabilità. In sostanza, uno spaccato di vita degli antenati delle comunità lagunari d’oggi, di cui a pieno titolo quella di Equilo è rappresentativa.

La vita della laguna era scandita anche dalla presenza delle comunità religiose, quelle monastiche in particolare. Lei ha inoltre indagato uno dei monasteri più iconici della laguna delle origini, quello dei Santi Ilario e Benedetto a Dogaletto di Mira: cosa sa dirmi in proposito?
Forse non tutti sanno che dei sei monasteri benedettini documentati nella laguna dell’alto medioevo (tre urbani, tre extra urbani), quello ora nel territorio di Mira ha restituito le evidenze materiali più intriganti del periodo: sarcofagi, lapidi iscritte, frammenti di mosaici policromi pavimentali. Questi materiali sono ancora conservati a Venezia nel cortile del Museo archeologico. Tuttavia, nel tempo si era persa anche la nozione esatta dove si trovasse questo monastero. Le ricerche che abbiamo iniziato nel 2009-10, e ripreso un paio di anni fa, stanno rivelando una documentazione archeologica di straordinario interesse. Non solo sono stati di nuovo identificati i resti di una grande chiesa a tre navate di XII secolo, scavata nel XIX secolo, ma sono emerse testimonianze rilevanti delle fasi alto-medievali del monastero: le cucine, forse il refettorio e una aula di culto della fine del X secolo, totalmente ignota. Le ricerche sono ancora in corso – e dunque premature ulteriori anticipazioni -, ma indiscutibilmente ciò che sta emergendo ci introduce in un’altra significativa realtà della Venezia delle origini.
Tornando alla Venezia delle origini, non si può certo dimenticare il fatto che Venezia è un insediamento nuovo che deve parte della sua fortuna alla dimensione economico-commerciale che seppe assumere abbastanza precocemente nell’alto medioevo. Tuttavia, esiste un altro insediamento, nell’arco nord Adriatico, che presenta caratteristiche simili – certo meno noto di Venezia ma tra VIII e IX secolo non meno importante: Comacchio. So che lei ha fatto ricerche a lungo anche su Comacchio: perché?
Ho sempre pensato che per capire meglio Venezia non si potesse fare a meno di conoscere quale fosse la realtà insediativa contemporanea nell’area nord Adriatica. Comacchio è stata dunque un’altra formidabile opportunità per me. Del resto, anche le fonti scritte, nei pochi documenti rimasti, avevano spesso associato i due insediamenti (vogliamo dire le due città?), spesso visti in competizione. Ma anche per Comacchio la realtà archeologica aveva restituito pochissimo. L’opportunità di iniziare le ricerche nei primi anni Duemila, attraverso scavi urbani e suburbani, ci consentì dunque di studiare un’altra Venezia – questa volta alle foci del Po-, diversa per alcuni aspetti, ma molto simile per altri, che aveva sviluppato una precoce vocazione commerciale già verso la seconda metà del VII secolo. L’esperienza su Comacchio è stata poi determinante per avviare un dialogo scientifico con i ricercatori che, da anni, studiavano gli empori altomedievali del nord Europa – un fenomeno che trovava diversi punti di contatto con le nostre realtà lagunari. Un altro modo per approfondire le conoscenze tra centro-nord Europa e Mediterraneo in uno dei periodi meno conosciuti della nostra storia medievale. In poche parole, inserire Venezia nel contesto nord Adriatico associandola a Comacchio, ci ha consentito di recuperare e potenziare quelle relazioni che anche la più recente storiografia aveva in parte abbandonato.
Lei ha concluso da poco la sua carriera a Ca’ Foscari. Come è cambiata l’archeologia dai suoi esordi a oggi? Come si è evoluta l'archeologia moderna e quanto sono importanti le innovazioni tecnologiche nel contribuire a fornire altri elementi per la comprensione e la ricostruzione del passato?
La ricerca è molto cambiata da quando sono arrivato a Ca’ Foscari nel 1997 ed è molto cambiata anche la stessa ricerca cafoscarina. In generale, oggi siamo sempre più consapevoli che la moderna tecnologia non ci mette a disposizione solo meri strumenti tecnici, ma ci aiuta anche a modificare il nostro approccio teorico al patrimonio archeologico. Da questo punto di vista anche l’archeologia cafoscarina ha registrato un notevole sviluppo negli ultimi anni, sia in termini quantitativi (numero di ricercatori) che qualitativi, guadagnandosi sempre di più una centralità nell’ambito della ricerca d’Ateneo. Peraltro, essa si è dimostrata fondamentale nei rapporti che ha saputo creare con le attuali comunità, affrontando un tema che si pone, da qualche tempo, al centro della riflessione archeologica, a tal punto da mettere in crisi anche consolidati valori e certezze. È un passaggio non semplice, difficile da accettare soprattutto per quanti sono cresciuti all’interno di un sistema di valori messo in discussione costantemente dalla modernità. Tuttavia, è un passaggio ineludibile, non solo perché non si può eludere la contemporaneità, ma perché effettivamente ci orienta verso una diversa ed aggiornata idea di patrimonio collettivo – e tocca le ragioni più profonde della nostra missione.