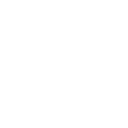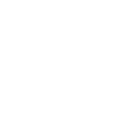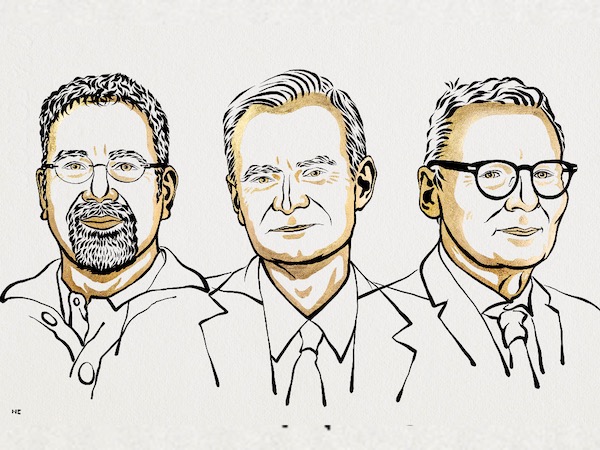«Vede quella macchia scura? Ecco, quello è il mio scavo». Paolo Biagi indica un punto ben visibile sulle foto satellitari di google maps, una piccola anomalia nella monotonia dei tavolati calcarei che accompagnano il versante orientale della Valle dell’Indo. Nel 1985, salito per la prima volta il pendio che porta a traguardare quelle mesas, Biagi capì che la mano dell’uomo era intervenuta, modellandole. In quello scavo avrebbe poi scoperto le prime miniere di selce nella regione del Sindh, odierno Pakistan. (Mappa)
«Nessun archeologo si era avventurato in quei luoghi prima di noi – racconta il professore di Preistoria e Protostoria al Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea – perché tutti si interessavano alle grandi città della valle, mentre la mia curiosità mi portava a cercare altrove per scoprire, ad esempio, quanto fosse importante la selce nell’economia delle civiltà della Valle dell’Indo, che raggiunsero la massima espansione territoriale e il più elevato sviluppo intorno a 4500 anni da oggi».
Quelle scoperte hanno permesso di comprendere la vastità del più ricco territorio minerario del subcontinente indiano per quanto riguarda la selce. Quattro anni di scavi hanno rivelato tutto sullo sfruttamento di questa risorsa: come veniva estratta, quali classi sociali erano coinvolte e le varie professionalità impiegate, la selezione, il trasporto, per terra o per fiume, verso le grandi città. Gallery
Vantando trent’anni di archeologia in Pakistan, Biagi è uno dei massimi studiosi della regione. La Shah Abdul Latif University di Khairpur gli conferì la medaglia d’oro nel 1999 per l’attività sulle miniere delle Rohri Hills. Il più recente riconoscimento è giunto alla Shaheed Benazir Bhutto Women University di Peshawar, dove Biagi è stato appena nominato visiting professor.
Il Pakistan è un paese in piena crescita. L’Italia è il terzo partner commerciale europeo dopo Regno Unito e Germania. In questo contesto, nascono e crescono università aperte alla collaborazione con atenei di tutto il mondo. L’università di Peshawar progetta l’apertura di un Dipartimento di Archeologia e conta proprio sul supporto di Ca’ Foscari per la didattica. Ca’ Foscari, inoltre, ha siglato nei giorni scorsi un accordo con l’università Quaid-i-Azam di Islamabad per scambi di studenti e docenti.
«Il Pakistan ha bisogno di aiuto per la formazione di una nuova classe di archeologi – spiega Biagi – l’Italia ha una posizione privilegiata nell’area, grazie a un interesse nato all’inizio del Novecento col Duca degli Abruzzi e coltivato da insigni studiosi. A Islamabad ci sono studenti molto promettenti provenienti da tutto il paese. A Ca’ Foscari si sono già formati tre archeologi pakistani, un nostro dottorato, Ghani ur Rahman, è da pochi giorni il nuovo direttore del Taxila Institute of Asian Civilizations della Quaid-i-Azam. Il nostro ateneo, quindi, è in prima fila per rappresentare l’università italiana nella regione, formare studiosi, continuare l’attività archeologica nel paese».
Ma che cos’ha ancora da rivelare l’archeologia in Pakistan? «C’è tantissimo lavoro da fare – risponde Paolo Biagi – sia nell’area nord-occidentale, dove Alessandro Magno si fermò alcuni anni, sia nella parte meridionale». Nel sud, infatti, si è concentrata l’attività di ricerca del team guidato da Biagi negli anni recenti, prima nel Sindh meridionale e poi nella provincia di Las Bela in Balochistan.
Nella regione del Lago di Siranda la missione cafoscarina ha riconosciuto più di settanta insediamenti preistorici. Le informazioni raccolte hanno permesso anche di formulare nuove ipotesi sul passato dell’ambiente e del clima della costa settentrionale del Mare Arabico: il lago, oggi isolato e alimentato dalle piogge monsoniche, fino a 5000 anni fa era una rada marina. Probabilmente, sostengono gli archeologi, Alessandro Magno si accampò proprio nei pressi dei mangroveti lungo le sponde del lago di Siranda durante il difficile ritorno verso Babilonia.
Oltre che sfida scientifica, quella dell’archeologia in Pakistan è anche sfida culturale. Molti siti già scavati o promettenti sono stati compromessi dalle attività umane. «Purtroppo i nostri risultati e le decine di pubblicazioni non hanno portato alla conservazione dei siti – fa sapere Biagi – nonostante le leggi prevedano la tutela, ad esempio, le mesas sono sfruttate dalle industrie di estrazione del calcare. La distruzione dei siti del subcontinente è soprattutto opera di attività industriale, commerciale e di sviluppo urbano, che finiscono per cancellare il patrimonio archeologico più di quanto non facciano le operazioni belliche».
Enrico Costa