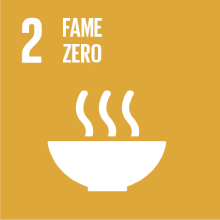AMERICAN THEORY
- Anno accademico
- 2025/2026 Programmi anni precedenti
- Titolo corso in inglese
- AMERICAN THEORY
- Codice insegnamento
- LMJ520 (AF:576762 AR:323764)
- Lingua di insegnamento
- Inglese
- Modalità
- In presenza
- Crediti formativi universitari
- 6
- Livello laurea
- Laurea magistrale (DM270)
- Settore scientifico disciplinare
- L-LIN/11
- Periodo
- II Semestre
- Anno corso
- 1
- Sede
- VENEZIA
Inquadramento dell'insegnamento nel percorso del corso di studio
All'interno di questo quadro generale, il corso costruisce sulle competenze già acquisite negli anni precedenti (soprattutto vocabulary e comprehension) per rafforzarle e sviluppare nuove capacità di analisi e interpretazione. La descrizione dettagliata del corso sarà disponibile sulla pagina Moodle (Syllabus).
Risultati di apprendimento attesi
(conoscenze e capacità di comprensione)
• conoscenza dell’evoluzione della critica letteraria negli Stati Uniti dalla fine degli anni Sessanta ai nostri tempi
• leggere, comprendere e interpretare testi e saper entrare in conversazione con loro
• creare collegamenti tra idee e/o autori diversi, comprendendone il contributo specifico al dibattito accademico e alla ricerca
(applicazione delle conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi)
• saper individuare una questione importante in maniera autonoma
• saper riconoscere gli strumenti teorici offerti dai materiali del corso;
• Saper tracciare le differenze tra i vari autori e i contributi all’evoluzione del discorso critico
• Saper approfondire gli argomenti di maggior interesse attraverso ricerche in biblioteca
(capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità)
• Acquisire familiarità con la scrittura accademica attraverso lo studio dei materiali
• saper strutturare un breve componimento secondo le convenzioni della scrittura accademica
• Saper circoscrivere un argomento di interesse o problema importante
(comunicare in modo chiaro)
• riassumere e parafrasare testi complessi, coglierne l’argomentazione principale
• prendere parte a un dibattito presentando un punto di vista e offrendo un contributo
• collaborare con i pari durante la discussione dei testi, nell’organizzazione di un dibattito, e
articolare le proprie impressioni a beneficio degli altri
(capacità di apprendimento)
• sviluppare capacità argomentative
• riassumere, parafrasare e citare fonti
• Entrare in dialogo con le idee e con gli autori oggetti del corso
Prerequisiti
Contenuti
Theodor W. Adorno
Fredric Jameson
Jacques Derrida
Hèléne Cixous
Mikkail Borch-Jacobsen
Terese De Lauretis
Michel Foucault
Judith Butler
Barbara Christian
Henry Louis Gates
Eve K. Sedgwick
Roberto Esposito
Rita Felski
Testi di riferimento
Julian Wolfreys, ed., Literary Theories: A Reader and Guide ( Edinburgh University Press 1999), parti scelte
e
Theodor W. Adorno and Horkheimer, “The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception” (1947)
Judith Butler, “What is Critique?” in The Judith Butler Reader, ed. Sara Salih (2004)
Barbara Christian, “The Race for Theory,” in Cultural Critique (1987)
Hélène Cixous, “Writing and the Law,” in Readings: The Poetics of Blanchot, Joyce, Kafka, Kleist,
Lispector, and Tsvetayeva (1991)
Jacques Derrida, “Différance” (1968), In Margins of Philosophy, trans. Alan Bass (1982)
Roberto Esposito, Living Thought (2012), excerpts
Rita Felski, The Limits of Critique (2015) excerpts
Henry Louis Gates, The Signifying Monkey (1988), excerpts
Terese De Lauretis, “Through the Looking Glass,” excerpts, in Alice Doesn’t: Feminism, Semiotics, Cinema (1984)
Teresa De Lauretis, “Strategies of Coherence: Narrative Cinema, Feminist Poetics, and Yvonne Rainer,” in Technologies of Gender (1987)
Fredric Jameson, Marxism and Form (1971), “Introduction”
Eve K. Sedgwick, “Paranoid Reading and Reparative Reading, or, You’re So Paranoid, You Probably Think This Essay is About You,” in Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity (2003)
Testi consigliati
Derek Attridge, "This Strange Institution Called Literature: An Interview with Jacques Derrida,” in Acts of Literature, ed. Derek Attridge (1992)
Tim Campbell, “Introduction,” Diacritics, Vol. 39, No. 3, Contemporary Italian Thought (Fall 2009)
Jacques Derrida, “Che cos’è la poesia” (1988), A Derrida Reader: Between the Blinds, ed. Peggy Kamuf (1991)
Roberto Esposito, “German Philosophy, French Theory, Italian Thought,” in RSA Journal 26 (2015)
Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language (1974), excerpts (2: The semiotic chora ordering the drives and 10: The Signifying Process)
Mena Mitrano, “Between Suspicion and Love: Reality, Postcritique, and Euro-American Modernization (An Introduction to the Debate),” in Review of International American Studies Vol. 13, Fall—Winter № 2 (2020)
Modalità di verifica dell'apprendimento
• esame scritto
• esame orale
L’esame scritto: Si articolerà un numero di prompts o inviti alla scrittura, con un numero di righe, miranti a verificare la conoscenza dei materiali del costo con particolare attenzione alla conoscenza degli strumenti teorici offerti dai materiali e dalla capacità di discussione autonoma, integrata alla capacità di proporre ed elaborare collegamenti tra autori, testi, e/o idee.
L'esame orale: durerà 20 minuti si articolerà nella forma di una conversazione. Lo scopo della conversazione è: a) discutere l’esame scritto; b) approfondire la verifica della conoscenza dei materiali del corso, con particolare attenzione alla conoscenza degli strumenti teorici offerti dal corso e alla capacità di discussione autonoma, integrata alla capacità di proporre ed elaborare collegamenti tra autori, testi, e/o idee.
Modalità di esame
Graduazione dei voti
Il voto minimo è 18, il voto massimo è 30 e lode. Per quanto riguarda la gradazione del voto (modalità con cui saranno assegnati i voti), si considerano 3 fasce:
La prima fascia: 18-22 (livello di base corrispondente a C nel sistema statunitense): sufficiente conoscenza dei contenuti; limitata capacità di analisi del testo; limitata conoscenza degli strumenti teorici; limitata capacità di collegare testi e/o autori.
La seconda fascia: 23-26 (livello intermedio corrispondente a B nel sistema statunitense): discreta conoscenza dei contenuti; discreta capacità di analisi del testo; discreta conoscenza degli strumenti teorici; discreta capacità di collegare testi e/o autori.
La terza fascia: 27-30 (livello buono o ottimo corrispondente a A nel sistema statunitense): buona o ottima conoscenza dei contenuti; buona o ottima capacità di analisi del testo; buona o ottima conoscenza degli strumenti teorici; buona o ottima capacità di collegare testi e/o autori.
La Lode è attribuita per evidenziare un livello eccellente della conoscenza dei contenuti, della capacità di analisi del testo, della conoscenza degli strumenti teorici, e della capacità di collegare testi e/o autori.
Metodi didattici
studenti apritori
dibattito e discussione
Altre informazioni
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Questo insegnamento tratta argomenti connessi alla macroarea "Povertà e disuguaglianze" e concorre alla realizzazione dei relativi obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile