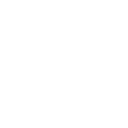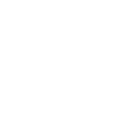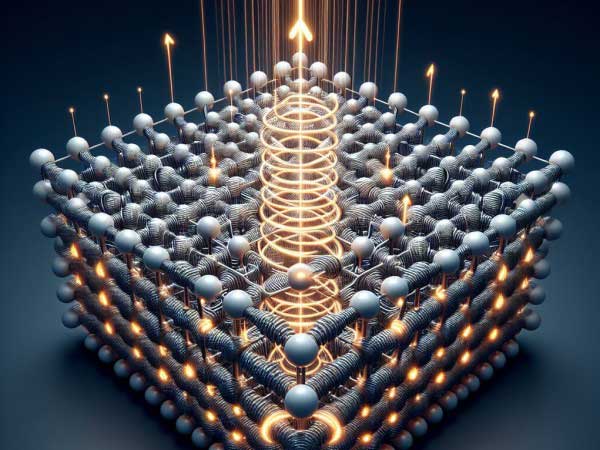Il professor Edoardo Gerlini, docente di giapponese classico del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, ci racconta il progetto che ha realizzato nell’ambito Marie Skodowska-Curie Global. Si tratta di WHEREAL: World Heritage and East Asian Literature – Sinitic writings in Japan as Literary Heritage, incentrato sul rapporto tra letteratura e heritagisation, ovvero i processi che portano alla formazione del patrimonio culturale (heritage), nazionale e non. Sotto la supervisione del professor Bonaventura Ruperti a Ca’ Foscari e della professoressa Kimiko Kono della Waseda University, il progetto si è concentrato su testi in kanbun risalenti all’VIII e IX secolo, adottando, però, un approccio insolito: inserendosi nel filone degli heritage studies, e proponendo la nuova categoria del textual heritage, la ricerca ha evidenziato come l’idea di patrimonio culturale in generale abbia implicazioni ben più ampie di quanto si possa immaginare, non soltanto attraverso il tempo, ma anche nella nostra contemporaneità. In questa intervista, il professore ci spiega perché.
Cos’è il kanbun e perché si è concentrato proprio su di esso in rapporto alla cultural heritage?
Kanbun è il modo giapponese di chiamare il cinese classico, cui negli ultimi tempi ci si riferisce spesso con i termini “sinitico” o “scrittura sinitica” proprio per smorzare il legame con la Cina contemporanea e sottolineare che non si tratta semplicemente della lingua della Cina del passato, quanto e soprattutto di una forma di scrittura che fungeva da lingua franca per tutta l’Asia Orientale, un po’ come il latino nel medioevo europeo. Anzi, come è avvenuto in altri Paesi dell’Asia Orientale, la scrittura in Giappone è nata proprio come scrittura sinitica, sia per quanto riguarda i caratteri di scrittura, sia per le lo stile e le modalità di costruzione dei testi, proprio perché l’unico modello disponibile in quel momento era quello continentale.
Il punto di partenza della ricerca non è del tutto originale, perché il recupero della tradizione letteraria giapponese in kanbun è avviato ormai da circa un ventennio e ha permesso di ricollocare il Giappone in un contesto culturale più ampio. La novità della ricerca, invece, è lo studio del kanbun da una prospettiva di heritage studies. Si tratta di un’area di ricerca interdisciplinare, tanto che in quasi tutte le discipline delle Humanities e Social Sciences troviamo qualche tentativo di indagare il significato dello heritage nel proprio ambito, ma gli studi letterari e, in particolare, la filologia non si erano ancora posti questi interrogativi, salvo pochissime eccezioni. Ho deciso quindi di applicare la teoria degli heritage studies alla filologia giapponese dei testi sinitici: si tratta di letteratura giapponese o cinese? Fino a tempi molto recenti, il kanbun era usato correntemente dagli intellettuali, molte persone di media cultura erano in grado di leggerlo e i documenti ufficiali più importanti, pensiamo alla prima costituzione giapponese di epoca Meiji (1889), erano scritti sostanzialmente in sinitico. Non bisogna poi dimenticare che il Giappone, inoltre, è l’unico Paese al mondo dove i caratteri cinesi - in giapponese, kanji - sono usati correntemente, cosa che non avviene più neanche in Vietnam o in Corea, che li avevano da sempre utilizzati adottati. Questi aspetti rendono interessante pensare la scrittura classica in termini di heritagisation, cioè del processo per cui noi, nel presente, decidiamo perché un certo elemento del passato sia parte del nostro bagaglio culturale. Sembrerebbe un tema particolarmente attuale e molto moderno, ma che in realtà è sempre stato presente nella storia. A quando possiamo far risalire questo processo nel caso del kanbun?
La mia ricerca, quindi, si è concentrata principalmente su testi premoderni scritti in Giappone usando il sinitico. L’obiettivo era stabilire da quale momento si possa parlare di cultural heritage e in quale modo i giapponesi dell’epoca si rapportassero alla cultura sinitica e l’abbiano fatta loro. Allo stesso tempo, la prospettiva degli heritage studies permette di arrivare a conclusioni interessanti, rivedendo il Giappone non solo in quanto tale, ma come attore all’interno di uno scenario culturale specifico, alternativo al nostro mondo occidentale ma che presenta dei punti di contatto con esso. Pensiamo al problema della digliossia, cioè l’utilizzo da parte della stessa comunità di due lingue con funzioni e scopi diversi, condizione che viviamo ancora oggi a causa della predominanza dell’inglese, per esempio nelle pubblicazioni accademiche. In che modo questo bilinguismo condiziona il rapporto con la “nostra” cultura? Come muterà l’identità linguistico-culturale europea nei prossimi anni?
Cos’è emerso dalla ricerca?
In particolare, mi sono occupato dell’analisi delle prefazioni di alcune antologie poetiche risalenti all’VIII e IX secolo, testi scritti in Giappone usando il sinitico. In queste prefazioni, i compilatori delle raccolte spiegano le motivazioni dietro la loro selezione: spesso, sottolineano che il primo obiettivo era far sì che questi esempi di scrittura “sublime” non andassero perduti, quindi proteggere un cultural heritage testuale e scritto. Mi sono sempre occupato di poesia, quindi questo focus è sorto abbastanza naturalmente, ma questi testi sono particolarmente significativi in termini di heritagisation. Per esempio, una delle raccolte poetiche giapponesi più importanti, il Kokinshū (X sec.), ha una prefazione in sinitico, nella quale si cerca però di dimostrare il valore della poesia in giapponese: si tratta di una strategia simile a quella operata da Dante per il volgare italiano nel De vulgari eloquentia (in latino).
Un aspetto cui ho dedicato particolare attenzione è stato il fatto che gli autori di questi testi si approprino di esempi della tradizione continentale per fini che potremmo dire “personali” - per esempio, per dimostrare le virtù dell’imperatore giapponese di cui erano sudditi, lo paragonavano agli imperatori mitici dell’antichità cinese. In altre parole, gli autori giapponesi si appropriano di un patrimonio testuale o textual heritage per rispondere ad esigenze presenti e “locali”. Questo è un esempio di heritagisation. Heritage non è infatti il passato in quanto tale, ma solo quella parte di passato che interessa in un certo “oggi”, e che è oggetto di pratiche culturali e sociali di selezione e valorizzazione.
Quale influenza ha avuto la pandemia sul suo lavoro?
Come per molti altri, la pandemia è stata un imprevisto che, all’inizio, ha influito negativamente sugli ultimi appuntamenti del progetto. Con il passaggio online, però, siamo riusciti a recuperare e, anzi, ci si sono aperte altre opportunità. Per esempio, abbiamo potuto organizzare un workshop sul tema del textual heritage cui hanno partecipato 200 studiosi da tutto il mondo; tra i partecipanti a questo workshop c’era anche il prof. Edward Kamens, dell’Università di Yale, che si era già occupato in precedenza del del rapporto tra letteratura giapponese e material culture, e che a sua volta mi ha invitato a tenere una lecture in uno dei seminari di Yale, cosa che non sarebbe stata possibile senza la “svolta digitale”.
Anche il periodo a Waseda è stato molto proficuo, perché ho avuto comunque modo di spostarmi prima delle chiusure. Nel 2019, ho trascorso un mese a Harvard per la summer school dell’Institute of World Literature e, alla fine dello stesso anno, ho potuto presentare la mia ricerca durante un un workshop dell’Università di Pechino organizzato in collaborazione con la professoressa Kono.
La parte forse più penalizzata del progetto è stata il contatto con le istituzioni europee che si occupano di cultural heritage, a causa delle difficoltà di spostamento legate alla pandemia, ma almeno le intenzioni che riguardavano i corsi a Ca’ Foscari sono state rispettate. Anzi, una delle conseguenze della pandemia è stata la possibilità di acquistare libri antichi in Giappone con i soldi che non ho potuto spendere negli spostamenti in Europa. Nell’ottica di riportare a Ca’ Foscari quanto ho imparato, vorrei poter far studiare i miei studenti sui testi fisici quando potremo tornare in classe. Uno dei risultati finali del progetto che ha subito qualche ritardo sarà anche la redazione di un manuale di kanbun in collaborazione con la professoressa Kono.
Quanto è penetrato il concetto di cultural heritage nella società civile e in che modo permette di fare un discorso sui classici? I testi sono riconosciuti come cultural heritage nelle liste UNESCO?
L’iniziativa UNESCO sull’Intangible Cultural Heritage prevede due liste: una è dedicata al cosiddetto “endangered heritage”, come le lingue in pericolo o minoritarie, mentre l’altra - cosiddetta representative list - ha lo scopo, un po’ controverso, di rappresentare la diversità culturale del mondo, per elementi più o meno a rischio. Ci si aspetterebbe che in questa seconda lista compaiano, per quanto riguarda la letteratura, i testi più rappresentativi di ciascuna tradizione linguistica, solo che ciò non avviene: la Divina Commedia, per esempio, è indubbiamente parte del patrimonio culturale italiano, ma non è presente nelle liste UNESCO; lo stesso avviene per molte altre grandi opere letterarie spesso indicate come “world literature”.
Cercando di indagare cosa significhi, quindi, textual heritage, ho organizzato un workshop a Waseda e un simposio, Textual Heritage for the 21st century, a Ca’ Foscari in collaborazione con l’ex-cafoscarino Andrea Giolai dell’Università di Leiden. Ci siamo domandati se si possa definire il testo come heritage e quali siano le conseguenze. La risposta non si è rivelata né semplice né univoca, quindi possiamo dire che uno dei risultati principali della mia ricerca Marie Curie sia stato quello di aprire la strada a nuove ricerche e approfondimenti. Un aspetto molto importante del simposio è stato il dialogo con studiosi di altre discipline e altre aree di ricerca: ci sono stati interventi sui classici indiani e la danza, o sui canzonieri in lingua spagnola di una comunità ebraica del mediterraneo, sulle tecniche di partitura della musica di origine cinese in Giappone o sulle iscrizioni nelle piramidi egizie e il passaggio da disegno a scrittura - quest’ultimo intervento a cura dei colleghi cafoscarini Emanuele Ciampini e Francesca Iannarilli. Tutti i partecipanti avevano l’obiettivo di capire cosa succede al testo una volta che questo viene passato alle generazioni successive, cioè quando diventa textual heritage. È stato indubbiamente uno dei risultati migliori dei tre anni, anche perché il workshop a Waseda, in giapponese, non ha potuto attrarre una comunità scientifica tanto trasversale e interdisciplinare.
L’heritage permette quindi di uscire dagli schemi in cui a volte ci ripieghiamo, confrontandoci anche con chi si occupa di periodi e discipline diverse, come l’economia o la giurisprudenza. Questa varietà si è vista nel panel che ho curato durante la quinta conferenza biennale organizzata dall'Association of Critical Heritage Studies nell'agosto del 2020: alla stessa discussione hanno partecipato esperti che andavano da un architetto e urbanista a un’esperta di mappe storiche - anche questa una ex-cafoscarina, Sonia Favi - e il direttore del Venice Centre for Digital and Public Humanities (VeDPH), Franz Fischer. Tutti questi momenti hanno fatto emergere la validità di questo approccio trasversale - l’ambizione è quella contribuire al rinnovamento delle humanities nel XXI secolo, ma per ora ci stiamo limitando a un volume miscellaneo che raccolga questi primi contributi.
L’esigenza di ripensare la cultura - nella mia ricerca, a partire dalla letteratura giapponese e dall’idea di heritage in relazione a questi testi - è però sempre parte delle preoccupazioni della società civile, anche da un punto di vista politico, e la filologia può aiutare a evidenziare questa esigenza. Quando l’imperatore Naruhito è salito al trono il primo maggio del 2019, il nome della nuova era corrispondente al suo regno è stato ufficializzato come Reiwa (令和), un’espressione tratta da un passaggio di una delle più importanti raccolte poetiche giapponesi, il Man'yōshū (VIII sec.): l'allora primo ministro Shinzo Abe, durante la successiva conferenza stampa, sottolineò la natura intimamente giapponese di questa espressione, glissando sul fatto che il passaggio in questione è una prefazione scritta in sinitico, con espliciti riferimenti alla cultura cinese delle Sei Dinastie. è un esempio attualissimo di appropriazione e riutilizzo - per qualcuno addirittura un abuso - della cultura passata e del textual heritage sinitico.
Anche lo stesso programma ICH ha implicazioni politiche importanti. Forse il meno eurocentrico tra i programmi UNESCO di questo tipo, è stato fortemente voluto dal Giappone (giapponese era anche il presidente UNESCO all’epoca), che si trova oggi al secondo posto per numero di elementi iscritti, dopo la Cina e davanti alla Corea. I paesi dell’Asia Orientale hanno quindi investito molto in questi processi. Lo stesso Monte Fūji è stato iscritto nella lista del World Heritage UNESCO, non come patrimonio naturale, ma culturale, proprio per il suo ruolo fondamentale nel contribuire alla formazione di un’identità nazionale giapponese. Queste dinamiche odierne riflettono spesso e volentieri la motivazione prettamente politica dietro certe scelte istituzionali di heritagisation, ma questo vale anche nel caso del periodo premoderno: anche le antologie di cui mi sono occupato sono antologie imperiali, ovvero delle iniziative che oggi definiremmo “statali” volute dall’imperatore con finalità che non si possono ridurre al semplice apprezzamento artistico.
Inoltre, nel discorso politico di oggi si tende a usare sempre più il termine heritage quando si parla di politiche culturali; forse però è il termine italiano patrimonio a sottolineare meglio che questo rapporto con il passato ha in realtà un valore importante, legato alla definizione di identità. Il mio studio si è concentrato sulla shared heritage di Giappone e Cina, ma lo stesso discorso vale anche per l’Europa e l’Unione Europea: qual è il nostro patrimonio culturale condiviso, quali ripercussioni ha sulla nostra identità culturale odierna? Chiedersi cosa sia il cultural heritage e come funzioni è importante e un punto di vista tanto distante come quello giapponese può rivelarsi molto utile, sia per quanto riguarda la definizione della propria identità culturale, sia per interrogarsi su supposti principi di universalità della cultura. In un mondo tanto interconnesso, guardare a contesti molto diversi - come il Giappone del IX secolo e l’Europa - ci mostra quanto la collocazione geografica di un paese sia importante nella definizione del proprio cultural heritage, ma anche quanto questo processo vada al tempo stesso oltre i confini fisici e politici tra gli stati. Il confronto con il passato, nel quale si tenevano atteggiamenti diversi rispetto alla cultura e alla tradizione, può aiutare a rivalutare e relativizzare le prospettive contemporanee e a rimettersi in gioco come attori dei processi odierni di heritagisation.
Nel mio piccolo, spero di aver mostrato che la filologia può avere un ruolo importante in questa dinamica, riportando l’attenzione su processi di costruzione e ricostruzione del patrimonio culturale che non sempre ci aspettiamo funzionino in questo modo: dopotutto, quando traduciamo un testo classico o ne proponiamo una nuova edizione stiamo facendo in effetti un’opera di heritagisation. Spero che questo progetto possa fornire uno stimolo ad altri colleghi “classicisti” per riposizionare il proprio lavoro nella società accademica e non del XXI secolo.