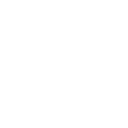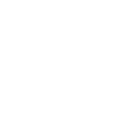Se oggi usiamo certe piante come alimenti e medicinali è merito di tradizioni evolute in secoli di storia. E’ possibile perdere questo prezioso bagaglio di conoscenza? Come cambia il nostro rapporto con le piante quando cambiano confini, etnie dominanti, politiche educative?
Per scoprirlo, l’etnobotanica estone Renata Sõukand ha creato un team di esperti (4 postdoc, 3 dottorandi, 3 assegnisti e 6 mediatori culturali per la ricerca sul campo) che sarà presto a contatto con minoranze etniche a cavallo di confini creati o spostati nell’ultimo secolo tra Estonia e Russia, Finlandia e Russia, Ucraina e Romania, Lituania e Bielorussia.
Sõukand ha ottenuto un finanziamento Horizon 2020 ERC Starting Grant di 1,5 milioni di euro per il progetto DiGe - Ethnobotany of divided generations in the context of centralization, che ha scelto di portare avanti a Ca’ Foscari, dove è diventata professoressa associata di Botanica al Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica.
Laurea in Farmacia e dottorato in Semiotica: un percorso fuori dagli schemi. Come ha incontrato l’Etnobotanica?
“Durante le superiori. Mia madre era un’appassionata e autodidatta collezionista di piante. Aveva molti libri e io l’aiutavo, sviluppando interesse per le piante. All’università avrei voluto studiare medicina, ma avendo vissuto per 6 anni in Russia e Ucraina avevo appena ripreso ad re-imparare l’estone e non ero certa di poter superare l’esame di lingua. Essendomi diplomata con una ‘medaglia d’argento’ l’ostacolo degli esami non si presentava per Farmacia e quindi mi iscrissi a quel corso. Fin dal primo anno di università, iniziai a frequentare l’Eesti Kirjandusmuusem (un centro di ricerca nazionale che promuove il patrimonio culturale estone, dove ho continuato lavorare con alcune pause fino a maggio 2017) per quella che diventò la mia prima ricerca sulla storia della medicina tradizionale estone. Per la tesi scelsi di occuparmi della medicina popolare tradizionale. Proseguii gli studi scientifici, ma parallelamente portavo avanti le mie ricerche sul folklore, il mio vero interesse. Il dottorato in Semiotica mi permise di continuare a lavorare sui miei database e sui libri sull’uso delle piante, interpretarli”.
Ha riscontrato differenti opportunità di carriera legate al genere?
“Non ho esempi o casi di riferimento perché mi sono sempre occupata di un campo così specifico e poco affrontato che mi sono sempre trovata a lavorare per conto mio e in piena libertà”.
Un’impresa solitaria che però a un certo punto è entrata in contatto con un network internazionale...
“Il mio primo incontro con un network internazionale avvenne solo durante il dottorato e fino ad allora il mio riferimento era solo la letteratura. Era come se stessi inventando qualcosa di già inventato, come la bicicletta. Da un certo punto di vista è un bene lavorare così in autonomia e trovare da soli la strada giusta, dall’altro mi ha portato a commettere tanti errori all’inizio della mia carriera. Ma solo facendo errori ti puoi correggere e andare avanti. Non ci sono chance di scoprire qualcosa se segui un percorso noto… devi trovare la tua strada. E questa probabilmente è la ragione per cui ho queste pazze idee... Poi, grazie alle conferenze internazionali in Canada e Messico ho conosciuto molti etnobiologi internazionali, e presto ho organizzato il primo incontro del network degli etnobotanici dell’Est europeo con il supporto e la guida di Andrea Pieroni, oggi rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, chi è stato il mio primo e unico mentore in campo dal 2014”.
L’obiettivo della ricerca è studiare l’effetto della centralizzazione politica sulla conoscenza tradizionale dell’uso delle piante. Perché?
“Quando andai alla prima conferenza, a Tofino, in Canada, portai un poster sul cambiamento dei nomi vernacolari delle piante. Evidenziava come nel diciannovesimo secolo in Estonia iniziò un processo che promuoveva l’uso dei nomi scientifici. Un singolo nome scientifico rimpiazzava molti nomi dialettali, nati in comunità chiuse come le parrocchie estoni. L’uso dei nomi tradizionali crollò negli anni Venti: per effetto della centralizzazione sovietica la scuola escluse i nomi tradizionali, non ufficiali e giudicati scorretti. La mia ipotesi è quindi che al termine di questo processo si sia diffusa una conoscenza standardizzata sull’uso delle piante, spazzando via la precedente conoscenza tradizionale. Nella ricerca in corso sto quindi verificando gli effetti di questo processo in vari gruppi etnici divisi dai confini e dalle lingue.
Come si svolge la ricerca? qual è il vostro laboratorio?
“Andiamo sul campo a intervistare persone, nelle loro case”.
E come selezionate le persone da intervistare?
“Il nostro non è un approccio sociologico. Le comunità che visitiamo sono piccole, di solito chiediamo chi è il depositario della conoscenza tradizionale. E’ un approccio intuitivo. Arriviamo sul posto con pochi punti di riferimento e parliamo anche con persone che inizialmente non emergono nel panorama locale. I ricercatori impegnati in questa attività sono molto esperti e sanno muoversi nei villaggi e trovare le fonti dell’autentica conoscenza tradizionale del posto. Intervistiamo esponenti delle minoranze, ma anche dei gruppi maggioritari”.
E cosa chiedete loro?
“Quali tipi di piante usano per cucinare, cosa mettono nella zuppa, nelle torte, nelle composte di frutta. Ma chiediamo anche quali rimedi utilizzano per problemi di salute, ad esempio cosa prendono quando hanno mal di testa, o cosa danno agli animali domestici quando si ammalano. E’ un questionario molto lungo. Dura un paio d’ore. Ma ci muoviamo senza fogli di carta: abbiamo tutto in testa, a cominciare dai nomi tradizionali dei disturbi e delle piante. Entriamo nel vivo delle domande solo dopo aver instaurato un rapporto di fiducia con l’intervistato. Prima del ricercatore, vedono l’essere umano interessato alle loro tradizioni. Da ogni intervistato torneremo prima della fine del progetto per colmare eventuali lacune”.
Ci fa un esempio di cosa trovate?
“La corteccia interna del tiglio era tradizionalmente usata in Estonia come medicinale per curare ustioni. Con il tempo questo utilizzo è quasi scomparso, mentre si è diffuso il consumo dei fiori di tiglio per preparare infusi. E’ stato interessante notare come la stessa persona ci nominasse il vecchio uso con il nome tradizionale della pianta e il nuovo utilizzo con il nome più recente. Due nomi per la stessa pianta, perché l’uso che ne viene fatto è cambiato. Queste sono informazioni interessanti per la nostra ricerca, dicono molto sui meccanismi di cambiamento nell'uso delle piante”.
Possiamo fare dei paragoni tra il rapporto con le piante degli italiani e delle popolazioni che ha studiato?
“Non ho ancora fatto studi sul campo in Italia, il mio livello di italiano non me lo consente ancora. Ma ho letto studi e conosco i dati. Posso dire che disponibilità e uso di piante e verdure selvatiche in Italia sono molto più ricchi che in paesi Est europei”.
Perché conoscere le piante dovrebbe essere ritenuto importante nelle società moderne?
“Noi possiamo pensare di avere tutto. Se guardiamo alla storia dell’umanità, non c’è mai stata continuità nell’abbondanza. Le piante sono il nostro cibo e il cibo degli animali di cui ci nutriamo. La nostra sopravvivenza dipende dalle piante. Ma è difficile usarle senza sapere come farlo, senza saper distinguere le velenose dalle commestibili e i modi per prepararle. Ci sono voluti secoli per imparare a usare le piante selvatiche, per esempio, e se perderemo questa conoscenza faticosamente costruita dovremo ricominciare da capo. E la domanda non è se la perderemo, ma quando la perderemo…”
E’ ottimista, nonostante tutto?
“Sì, sono ancora ottimista. Credo ci sia la speranza di un cambiamento nel modo di pensare. Abbiamo le potenzialità per vivere in pace, con rispetto e in modo sostenibile. Ma dobbiamo cambiare il modo di pensare”.
Possiamo dire che, in fondo, studiate le piante osservando gli umani?
“In un certo senso sì: come etnobotanici studiamo la relazione tra piante ed esseri umani. Le piante sono quindi uno strumento per capire la nostra attitudine al cibo e alla medicina. Costituiscono una connessione tra conoscenza tradizionale e scientifica. E’ una ricerca umanistica in questo senso. La competenza scientifica ci serve per identificare le specie, ma i nostri sono studi sulla cultura”.
Enrico Costa