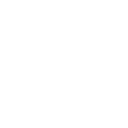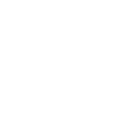Dazi del 25% sulle importazioni da Messico e Canada, del 10% dalla Cina. Questa è stata la prima dichiarazione di ‘guerra commerciale’ del neoeletto Presidente Trump, per il momento posticipata di un mese solo per i primi due Paesi. Quali conseguenze ci dobbiamo aspettare da queste misure, a livello globale ma anche nazionale e locale? L'abbiamo chiesto a Giancarlo Corò, professore di Economia Applicata al dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia
Professore, cosa sono e come funzionano esattamente queste misure? Su chi ricadono i costi?
Un dazio è una tassa sull’importazione di beni e servizi; perciò, il suo effetto immediato è alzare i prezzi nella spesa dei consumatori. L’idea che i dazi generino entrate fiscali a carico degli esportatori stranieri è falsa. Sarebbe come dire che le accise sulla benzina, molto simili a un dazio, sono pagate da chi ci vende il petrolio. In realtà, l’impatto effettivo della tariffa dipende da come domanda e offerta nel mercato reagiscono all’aumento dei prezzi. Beni essenziali e non facilmente sostituibili, come i farmaci importati negli USA dalla Cina e dall’Europa, o i prodotti alimentari importati da Messico e Canada, scaricano subito l’aumento tariffario sulle famiglie. La stima effettuata su un aumento del 10% delle tariffe su tutte le importazioni negli Stati Uniti, porta a una tassa aggiuntiva di 1.500 euro per ogni famiglia americana. Inoltre, gli Stati Uniti importano anche molti beni collegati a catene produttive create all’estero dalle stesse imprese americane. Messico e Canada riforniscono l’automotive USA per 90 miliardi di dollari l’anno, mentre dalla Cina arrivano computer e telefoni per circa 100 miliardi. Un dazio su questi beni ricade dunque sull’industria americana, che infatti, come denunciato dal Wall Street Journal, non è affatto favorevole a tale politica.
Come rispondono i Paesi coinvolti?
La risposta è stata immediata, con contromisure che dipendono anche dalle diverse strategie commerciali. L’80% delle esportazioni di Canada e Messico è destinato agli Stati Uniti, perciò una tariffa del 25% avrebbe colpito duramente le loro economie. Da qui la dura reazione dei rispettivi governi. Per la Cina è diverso, in quanto solo il 15% delle sue esportazioni è diretto negli Stati Uniti. Inoltre, va detto che la Cina era già stata colpita dalle politiche tariffarie della precedente amministrazione Trump, per altro confermate da Biden. L’impatto per la Cina è stato limitato in quanto ha spostato parte delle produzioni soggette a dazi in altri paesi, come Vietnam e Messico.
Allo stesso tempo, va sottolineato che gli Stati Uniti non hanno affatto ridotto il pesante deficit commerciale, che è passato dai 500 miliardi di dollari nel 2017 ai 900 di oggi. Questi numeri fanno capire che i dazi sono strumenti inefficaci per favorire l’industria nazionale e riequilibrare la bilancia commerciale. Diversa la valutazione se gli obiettivi sono altri, come negoziare maggiori controlli alla frontiera, frenare gli squilibri finanziari, limitare i trasferimenti di tecnologie sensibili.
Oppure se si propongono di rassicurare la propria constituency elettorale, come il ceto medio impoverito dai cambiamenti tecnologici, in particolare nelle regioni industriali della Rust Belt.
Questi obiettivi, tuttavia, possono essere meglio perseguiti attraverso politiche industriali e di welfare, oltre che con il rilancio delle istituzioni internazionali, anche al fine di una più equa tassazione dei grandi gruppi multinazionali.
Le Borse, compresa Wall Street, sono scese bruscamente dopo l’annuncio dei dazi. Perché?
Una politica commerciale unilaterale mette a repentaglio il sistema di scambi internazionali che ha creato, nel tempo, forti interdipendenze produttive e finanziarie. Per quanto nell’ultimo decennio gli scambi di merci abbiano rallentato, il commercio mondiale ha raggiunto a fine 2024 il suo massimo storico, ed è inoltre cresciuto il commercio internazionale dei servizi: da quelli tradizionali come il turismo, a quelli veicolati da reti digitali, quali finanza, comunicazione, software, entertainment, education. Oggi la somma di esportazioni e importazioni pesa più del 50% sul Pil mondiale, e buona parte di questi scambi è l’espressione di catene globali del valore che interconnettono le industrie moderne. Nessun paese, nemmeno il più grande, sarebbe oggi in grado di assicurare da solo la produzione di aerei, farmaci, computer o smartphone. Pure la produzione alimentare è oggi assicurata da approvvigionamenti di materie prime e processi di trasformazione che si sviluppano a scala globale. Colpire il commercio mondiale compromette queste complesse catene di fornitura, soprattutto quelle tecnologiche che contano su maggiori economie di scala, creando incertezza sui mercati finanziari.
Anche l’UE sarà nel mirino della politica economica americana? Quali sono i rischi?
Il deficit commerciale USA verso l’Unione Europea è di 150 miliardi di dollari, equivalente a quello del Messico e metà di quello della Cina. Questo squilibrio si è accentuato nel corso degli ultimi dieci anni, anche in conseguenza di diverse politiche fiscali, che hanno penalizzato consumi e investimenti in Europa. Le esportazioni sono state così la valvola di sfogo dell’industria europea.
Germania e Italia misurano i surplus bilaterali più elevati, perciò hanno più da perdere dalle politiche tariffarie di Trump. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che l’altra faccia dei surplus commerciali è il deflusso di risparmi verso il paese in deficit. Gli Stati Uniti hanno infatti raccolto in vari modi il risparmio europeo, a partire dai depositi in dollari, ai titoli della Fed, al mercato azionario, fino agli investimenti diretti delle imprese, destinati quest’ultimi a crescere per saltare le barriere tariffarie. Un riequilibrio commerciale potrebbe perciò portare benefici anche all’Europa, a condizione si favoriscano investimenti produttivi e tecnologici sul mercato interno, come propone giustamente il Rapporto Draghi.
Quali ripercussioni avremmo a livello nazionale e locale? Quali sono i settori più a rischio per l’Italia e per il Veneto in particolare?
L’Italia rischia di pagare cari i dazi di Trump. Non solo per i 75 miliardi di esportazioni su quel mercato, ma anche per quella parte di forniture meccaniche, farmaceutiche e della moda che arrivano negli Stati Uniti tramite le industrie tedesche e francesi. L’altro settore a rischio è quello
alimentare, che per l’Italia vale un surplus bilaterale con gli USA non distante da quello automotive. Su questo settore c’è anche il vino, voce che pesa molto nell’export veneto negli USA.
Nel complesso la nostra regione esporta negli Stati Uniti 8 miliardi di euro, il 10% del totale, in
particolare macchinari, occhialeria, moda, oreficeria. Grazie all’Osservatorio istituito da Unioncamere Veneto in collaborazione con il Dipartimento di Economia, possiamo monitorare in dettaglio le imprese più esposte: sono infatti 7.200 le imprese venete che esportano negli USA, e di queste quasi 3mila contano su questo mercato per oltre la metà del proprio export. Per ridurre il rischio tariffario le imprese devono perciò diversificare i mercati di sbocco, ma anche sviluppare nuovi modelli di business internazionale per avvicinarsi alla domanda finale. Dalle nostre indagini abbiamo visto come le imprese che meglio riescono in questa strategia sono anche quelle con una migliore dotazione di tecnologie digitali. L’indicazione, perciò, è che una politica per crescere sui mercati esteri non può essere disgiunta da una politica per l’innovazione.