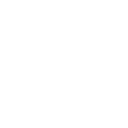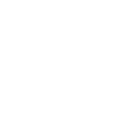Già nota traduttrice e poetessa bilingue di fama internazionale, con il suo romanzo d'esordio “L’istante largo” (ed. Bollati Boringhieri, 2020) ha già collezionato due ristampe in altrettante settimane. Stiamo parlando della cafoscarina Sara Fruner, trentina di nascita, veneziana di adozione e ora newyorkese per scelta, che il 14 ottobre sarà ospite del ciclo di incontri “Writers in Conversation” per presentare la sua prima opera in prosa ispirata al mondo di "Cent’anni di solitudine".
Ci racconti un po’ della tua esperienza a Ca’ Foscari?
Per il mio percorso universitario, avrei potuto rimanere nella mia regione d’origine e studiare a Trento, ma ho scelto, senza la minima esitazione, Ca’ Foscari.
C’era quel sussurro che sentivo sin da piccola, e che mi teneva sveglia nel mare della notte, un libro per scialuppa. L’altrove è sempre stato un luogo parlante molto familiare dentro di me; le lingue straniere, il veicolo più naturale per raggiungerlo. Quindi sono approdata a Venezia.
Non scordo la vertigine dei primi tempi. I momenti di frastornante disorientamento per la città, persa fra le sedi universitarie, la mappa sempre stretta in mano, le calli sempre di corsa sotto i piedi. Santa Marta e le Zattere, Ca’ Zorzi e Ca’ Bembo. Le corse!
Su quei banchi, in quelle aule, sono venuta al mondo infinite volte. A Ca’ Foscari, entri singolare, ed esci plurale.
La più grande scoperta è stata senza dubbio quella dell’altro, che per me è avvenuta grazie ai corsi di letteratura post-coloniale di lingua inglese che ho frequentato. Un altro da sé che, impari, è plurimo, parla idiomi diversi, produce letterature meravigliosamente variegate. Entri in contatto con i dolori dei popoli, la bellezza delle loro lingue, con l’amaro e il dolce del silenzio che intride tante scritture.
L’università mi ha insegnato a stare zitta e ad ascoltare — pagine, professori, persone — un dono che, da scrittrice e poeta, si è rivelato essere anche l’approccio metodologico più prezioso per il mio lavoro.
Ca’ Foscari sono le persone di Ca’ Foscari. I professori. All’inizio ti senti piccolissimo davanti a loro. Giganteggiano per saperi, esperienza. Ma negli anni la soggezione stempera, lascia il passo al confronto.
Oggi, alcuni di quei professori, ho l’onore di chiamarli amici, prima che colleghi. Shaul Bassi, Armando Pajalich, Marco Fazzini.
Quando mi sono laureata, sapevo di non averne avuto abbastanza. Dopo un primo master post-laurea in traduzione dall’inglese americano all’Istituto Superiore Interpreti e Traduttori di Milano, sono tornata a Ca’ Foscari, per il master post-laurea in traduzione dall’inglese, coordinato dalla Professoressa Rosella Mamoli-Zorzi.
Facevo i salti mortali per frequentare, lavorando, pendolando il fine settimana dal Trentino, ma non avrei rinunciato per nulla al mondo. Ho imparato a tradurre, in quei due anni e mezzo. Ho imparato anche
che la teoria della traduzione non è affatto anni luce dalla pratica della traduzione: orienta
il modo in cui puoi guardare un testo, e ti aiuta ad affrontarlo preparato.
Come sei entrata poi nel mondo dell’editoria? Hai un autore preferito da tradurre?
Nell’editoria sono entrata molto giovane, appena laureata. All’inizio fu manovalanza. Correttrice di bozze per Baldini&Castoldi.
Poi, al termine del master in traduzione di Ca’ Foscari, un tirocinio presso una casa editrice, opportunità
concessa a due studenti del corso. Ebbi la fortuna di essere una dei due, e di capitare da Archinto Editore, dove ho avuto modo di vedere come funzionava un editore piccolo e raffinato.
Nel frattempo, bussavo alle porte delle case editrici più grandi proponendo la traduzione di At the Full and Change of the Moon di Dionne Brand, un romanzo che avevo conosciuto proprio a Ca’ Foscari, nel corso di Letteratura dei Paesi di Lingua Inglese tenuto dalla Professoressa Franca Bernabei. Amai visceralmente quel romanzo, una straordinaria metafora della diaspora nera nel mondo. Non mi capacitavo di come un’opera così potente, di respiro così globale, non fosse ancora stata tradotta in italiano. Ero incredula. Indignata.
Dopo tanto ostinato bussare, una editor illuminata, Roberta Mazzanti, aprì la porta di Giunti Editore.
Tradussi quel romanzo, e il successivo di Brand. Scovai il capolavoro di Monique Truong, The Book of Salt, tradussi anche quello. Intanto, cominciai a collaborare anche come consulente editoriale e revisore classici. E mi avvicinai alla traduzione poetica: prima le liriche di Dionne Brand, poi del canadese Don McKay.
Di tradurre, non ho mai smesso, anche se in questi ultimi anni newyorkesi il materiale che ho per le mani riguarda l’arte del ‘900, mia grande passione. Traduco per Magazzino Italian Art, una bellissima realtà museale che si trova a Cold Spring (New York) e si dedica alla diffusione dell’arte italiana contemporanea e del secondo dopoguerra, in particolare l’Arte Povera.
Rimarrò sempre legata a Dionne Brand, autrice che non finisce mai, mente lucidissima con una penna affilata in mano e un cardellino in bocca. Ho cominciato con lei, con la sua prosa stratificata, dotta e robusta, lirica e immaginifica. Ho continuato con il dolenteincanto della sua poesia.
Quali sono secondo te le sfide del mestiere? Ci sono caratteristiche necessarie per diventare un bravo traduttore?
La miglior strategia che un traduttore può adottare è il dubbio. Un mio personaggio, ne L’istante largo, dice: “La lingua è un palazzo pieno di finestre e botole”. Credo che abbia ragione: le insidie, in una lingua, si nascondono ovunque, anche nella più innocua delle frasi. Non devi mai dare per scontato nulla.
Un bravo traduttore coglie l’intenzione prima di un’opera, e trova il codice per riversarla nella sua lingua, una ricerca che si rinnova di libro in libro. Riesce a far pace con il sacrificio a cui la traduzione lo costringe: qualcosa si perde sempre nel passaggio tra lingua di partenza e lingua di arrivo — a questo proposito, il filosofo Paul Ricoeur parla proprio di “lutto”. Tuttavia, questa condanna alla perdita non lo fa desistere. Testa bassa, occhio lungo e orecchio fino, il bravo traduttore non si stanca mai di cercare.
Curioso, diffidente, scontento e incontentabile, sa che la perfezione è un miraggio, eppure a essa tende sempre, mercanteggiando tutto il tempo con il perfettibile.
È un ludico che ama giocare con le parole, uno stuntman che schiva le trappole — le botole! — nascoste nelle lingue.
Soprattutto, è un navigatore, pronto a imbarcarsi in solitaria in acque sempre ignote. Mi sento tutte queste identità addosso — e molte altre — quando pratico il tradurre, l’arte e il mestiere che mi hanno portata a diventare la scrittrice che sono.
Come ti sei avvicinata al mondo della poesia? Da cosa ti fai ispirare nella composizione dei tuoi versi?
Io dico sempre che nasco poeta e morirò poeta. E questo non per spocchia o posa, ma perché la poesia, prim’ancora di essere una forma letteraria, è un accostarsi alla vita in un certo modo. Quello rimane sempre, che tu lo voglia o no.
Ho cominciato a scrivere versi, rigorosamente per me, intorno ai diciotto anni. Ho impiegato più di dieci anni a fare coming-out, come dico io, cioè a far leggere le mie cose, e a proporle in pubblico, confessare che componevo. Il poeta è sempre scettico e diffidente nei confronti di se stesso. Malvolentieri si dichiara — questo vale anche per Wislawa Szymborska, e lei è un Premio Nobel.
Più che di ispirazione, mi piace parlare di intuizione. Succede che vedo un dettaglio, un frammento di realtà, e che ne rimanga sedotta. Può essere una calza che esce da un cassetto, una goccia che precipita dal rubinetto. La maggior parte delle volte, però, la fascinazione scatta per le parole. È una reazione puramente sensoriale. Certe parole mi avvincono, mi si attaccano addosso. Io le raccolgo e le ripongo.
Ci ritorno. Ci giro intorno, me le rigiro in testa, in mano e in bocca. Ne chiamano altre, poi altre. Il legame non è mai logico. È molto spesso metaforico — direi anche metafisico. È, soprattutto, musicale.
In questo vitale processo della poesia, in cui il suono è cruciale, intravedo qualcosa di simile a un fenomeno biologico. Una parola attira un’altra parola: la cellula attira le sostanze nutritive per sopravvivere. Nella poesia, quelle sostanze sono suoni: si pongono accanto, o si oppongono, ad altri suoni. Ed è per questo che la mia poesia in inglese nasce in inglese e la mia poesia in italiano nasce in italiano. Ogni lingua mi permette di perlustrare territori emotivi diversi grazie ai mezzi semantici e sonori che mi mette a disposizione. Quindi non decido mai se scrivere una poesia in inglese o in italiano. È il verbo, con la sua musica, a decidere per me.
Come è nato 'L’istante largo' e quali temi hai voluto esplorare all’interno del tuo romanzo d’esordio?
L’idea di questo romanzo è nata molti anni fa. Scrissi un racconto in cui tre bambine molto diverse tra loro diventavano donne, prendevano strade diverse, ma rimanevano legate da una profonda amicizia. Il sodalizio era così forte che, a un certo punto, si incarnava in un cucciolo d’uomo, Macondo. Tre femmine forti che concepivano un maschio speciale, un ragazzo con il passato inciso nel nome, insieme a un chiaro riferimento a Cent’anni di solitudine.
Mentre seguivo quei personaggi, ne incontravo altri. Ma i limiti del racconto cominciavano a starmi stretti: avevo bisogno di più spazio per ospitarli tutti. Ho pensato che un romanzo fosse la casa più adatta.
Con la varietà di personaggi che accoglie, credo che L’istante largo sia diventato anche una casa per quelli che sentono di non conformarsi troppo alla norma o alla massa, sia perché vivono situazioni famigliari o relazionali non-standard, sia perché, magari, hanno una personalità non-standard. O perché vivono in strutture famigliari anomale.
Nel romanzo, la famiglia naufraga in ogni sua possibile declinazione. Appare come un’entità instabile, che si adatta alle circostanze e che può spuntare da situazioni in cui la carne non ricopre alcun ruolo. Questo, per mostrare la creatività dei rapporti, e soprattutto, per spostare l’attenzione dal vincolo genetico all’intesa elettiva. Dalla singolarità del consanguineo alla pluralità dell’affettivo.
Mi piaceva anche, accanto a questa polifonia di voci, raccontare il passato — per esempio attraverso la famiglia cilena della nonna di Macondo, e la storia dei mapuche — per dimostrare come il passato non sia mai veramente tale, ma continui a vivere dentro di noi nel presente, a fiorire sulla terra che siamo. Ho cercato, inoltre, di raccontare l’adolescenza, con i suoi eccessi, la sua tenerezza, la sua pericolosità. E anche l’amore, che pur essendo unico nella sua essenza, s’incarna in diverse splendide forme - eterosessuale, omosessuale, bisessuale, famigliare, amicale, intergenerazionale.
Nonostante la sua trama variopinta, L’istante largo è anche attraversato da un filo nero. Tutti i personaggi hanno subito un dolore e tutti — tranne uno — trovano la maniera di uscirne. Lo fanno tutti a modo loro. E questo conferma che le vie per ricominciare sono infinite. Credo che il senso primo e ultimo de L’istante largo stia tutto nell’epigrafe. “Da un campo nero, una foglia verde”.
Un’ultima domanda, hai opere in lavorazione delle quali puoi parlarci?
Ritornando alla traduzione… Da qualche settimana ho cominciato a tradurre per Bollati Boringhieri, Parakeet, il nuovo romanzo della scrittrice newyorkese Marie-Helene Bertino.
Quanto alla mia scrittura, sto lavorando al secondo romanzo, e a una raccolta di poesie. Prima della pandemia, a gennaio, ho completato un poema epico in canti che spero tanto vedrà la luce delle librerie, un giorno.
Per maggiori informazioni sull’appuntamento del 14 ottobre e per iscriversi all’evento, visitate la pagina dedicata.