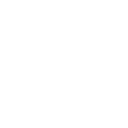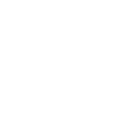Con il voto anticipato hanno già votato quasi 35 milioni di americani, e ormai il conto alla rovescia
per le elezioni presidenziali è giunto alle battute finali. Dopo una brillante scesa in campo di Kamala Harris, che ha ottenuto endorsement significativi - tra cui anche quello molto commentato di Taylor Swift -
il clima generale della campagna statunitense sembra ora pendere dalla parte di Donald Trump.
Secondo i sondaggi, in realtà, Trump e Harris sono 'testa a testa' e sembra ancora impossibile
individuare un vincitore. Ne abbiamo parlato con Duccio Basosi, docente di Storia delle Relazioni
internazionali a Ca’ Foscari.
Economia e immigrazione sono due temi prioritari per cittadini e cittadine americani che si
recano alle urne. Sono davvero questi i punti cruciali su cui si sfidano i due avversari, con
quali posizioni?
Direi di no. O, meglio, dipende. I sondaggi ci dicono di un elettorato tendenzialmente spaccato a
metà e incredibilmente polarizzato. Ciò si riflette anche nel fatto che gli elettori Democratici e
Repubblicani sembrano dividersi proprio in base a quali siano i temi a cui danno maggiore priorità.
Dai sondaggi risulta effettivamente che coloro che si dichiarano intenzionati a votare Donald
Trump lo faranno pensando soprattutto all’immigrazione (vista come un problema da arginare) e
all’economia (vista come debole). Ma coloro che dichiarano che daranno il proprio voto a Kamala
Harris lo faranno soprattutto pensando al diritto delle donne all’interruzione di gravidanza
(fortemente indebolito da una recente sentenza della Corte suprema) e alla tutela del sistema
costituzionale di pesi e contrappesi tra poteri e istituzioni (ritenuto a rischio in caso di vittoria
trumpiana). A margine va detto che, se per forza dell’economia si intende “disoccupazione
relativamente bassa + inflazione relativamente bassa” (come presumibilmente pensano sia Harris,
sia Trump), da quasi due anni l’economia statunitense dovrebbe essere ritenuta in forma più che
buona, ma una parte dell’elettorato sembra non esserne convinta. In ogni caso, è come se due
diversi elettorati giocassero due partite diverse.
Nel 2016 la promessa di Trump di difendere la "cultura" del Paese ha contribuito in maniera
significativa alla sua vittoria. La paura del cambiamento sociale è ancora un elemento
centrale?
Non so se si possa dire che Trump nel 2016 aveva promesso di difendere la “cultura” del Paese.
Aveva fatto campagna elettorale strizzando l’occhio all’etnonazionalismo “bianco”, a chi non voleva
una donna presidente e a chi si sentiva minacciato dalle migrazioni e dai beni di consumo importati
dalla Cina. E naturalmente razzismo, machismo e xenofobia sono sempre state parte del discorso
politico statunitense. Ma non c’è nessun motivo per ritenere che queste caratteristiche fotografino
la “cultura” statunitense, particolarmente in riferimento agli ultimi decenni. Ovviamente la “cultura”
è sempre terreno di conflitti e quali tendenze risultino egemoniche in un determinato periodo è il
risultato di questi conflitti. Ma anche senza andare troppo sul filosofico, ritenere che gli statunitensi
nel 2016 si identificassero naturalmente con idee razziste, machiste e xenofobe significherebbe
dimenticare che nelle due elezioni precedenti il vincitore era stato Barack Obama e che il voto
popolare nel 2016 lo vinse Hillary Clinton, con un messaggio che, in linea di principio, era di
apertura al mondo. Che poi nel 2016 questo messaggio non funzionasse più, o che Clinton non
fosse la candidata giusta per esprimerlo nei swing states, magari è vero, ma è un altro discorso.
L’etnia è uno dei fattori guida dell’elettorato americano? Se sì, come sta influendo sul voto?
L’etnia – negli Stati Uniti direbbero race – tradizionalmente è un fattore molto rilevante nelle
elezioni statunitensi. Dagli anni Sessanta, i Democratici sono stati sostenuti in modo massiccio
dall’elettorato afroamericano e ispanico, per limitarsi a quelli che nei censimenti statunitensi sono
considerati i due principali gruppi etnici “non bianchi”. Dagli anni Settanta i Repubblicani hanno
goduto di una maggioranza del voto “bianco”, anche se non schiacciante. I sondaggi del 2024
dicono che in linea di massima queste considerazioni valgono ancora, ma anche che Kamala
Harris sembra non raccogliere lo stesso grado di consenso presso gli elettori afroamericani ed
ispanici dei candidati democratici precedenti. Tuttavia, le analisi più recenti dicono anche che la
vera linea di faglia di queste elezioni sembra collocarsi all’intersezione tra genere e grado di
istruzione: in uno studio commentato in questi giorni sul New York Times, per esempio, Harris
risulta in vantaggio di 9 punti percentuali tra le donne, mentre Trump lo è di 8 punti percentuali tra
gli uomini; Harris prevale di 19 punti tra chi ha una laurea, Trump di 10 tra chi non ne ha una.
Mescolando i dati, Harris è avanti di 27 punti tra le donne laureate, Trump di 16 tra gli uomini non
laureati.
Per l’Europa, e per l’Italia in particolare, quale scenario si apre a seconda della vittoria di
Trump o Harris?
Se stiamo alle dichiarazioni, Harris sarebbe la candidata della continuità, per la sua enfasi retorica
sull’importanza della leadership statunitense nel mondo e sulla centralità delle alleanze degli Stati
Uniti con altri stati di tradizione liberaldemocratica. Per quanto riguarda l’Europa, ciò in linea di
principio significa un rinnovato investimento nella NATO e il mantenimento, almeno a breve
termine, dell’attuale atteggiamento di sostegno militare all’Ucraina e di rifiuto di qualsiasi forma di
dialogo con la Russia. Come si declinerebbe poi, in pratica, questo atteggiamento, è questione che
dipenderebbe da mille variabili che in questo momento non sono prevedibili. Invece Trump, a
parole, promette una rottura radicale con la pretesa statunitense di “guidare” il mondo, operazione
che ritiene dispendiosa e inutile. La sua ossessione è la competizione economica con la Cina e ciò
in teoria dovrebbe implicare un allentamento dei legami con l’Unione Europea. Come noto, Trump
ha promesso di far finire la guerra in Ucraina “in meno di 24 ore” grazie ai suoi buoni rapporti
personali con Vladimir Putin e alla sua promessa di interrompere il flusso di armamenti statunitensi
alle forze armate ucraine. Tuttavia, se la sua prima presidenza può essere presa come modello
per un’eventuale replica, la politica estera di Trump è ricordata soprattutto per la sua erraticità,
fatta di tweet contraddittori e mosse imprevedibili. Nel complesso, ciò generò molto stress e molta
confusione nelle cancellerie mondiali, ma non si può dire che il ruolo degli Stati Uniti nel mondo sia
mutato in modo significativo nel suo quadriennio alla Casa Bianca.
Quanto conta in queste elezioni la politica internazionale, e la posizione dei candidati sulla
Cina e sulle guerre tra la Russia e l’Ucraina, e tra Israele e la Palestina?
L’ultimo sondaggio New York Times/Siena College (pubblicato il 25 ottobre) dice che conta
relativamente poco: solo per il 3% degli intervistati la politica estera sembra la prima
preoccupazione. Il che non significa che non conti. Solo che in questa campagna elettorale essa è
rimasta offuscata, in quanto tale, da altri temi che, se mai, l’hanno inglobata: quando Trump
promette che rilancerà l’economia attraverso l’introduzione di alte tariffe commerciali, in definitiva
sta anche parlando di politica estera. Idem per Harris, quando accusa Trump di essere un pericolo
per la democrazia anche a causa della sua vicinanza a Putin. Per quanto riguarda le aree di crisi
specifiche, la guerra tra Russia e Ucraina è la prima preoccupazione per meno dello 0.5% degli
intervistati. Circa l’1% mette al centro dei propri pensieri un oggetto indefinito denominato “Medio
oriente/Israele/Palestinesi”, ma il sostegno alla politica israeliana, quale che siano le forme che
questa prende (incluse le più brutali), è questione su cui Harris e Trump si distinguono, al
massimo, per qualche sfumatura.
Secondo lei chi ha più paura? I Democratici una vittoria di Trump o i Repubblicani una
vittoria di Harris?
Credo che abbiano più paura i democratici. L’elettorato trumpiano sembra mosso da una fede
messianica nel suo leader e disprezza i democratici e le loro politiche, ma non sembra esprimere
“paura” in caso di vittoria di Harris. Il fatto che per i democratici sia in gioco la “democrazia” ci deve
invece far pensare che hanno molta paura delle conseguenze della vittoria dell’avversario. Nella
misura in cui Trump ha promesso che farà perseguire dai tribunali i suoi avversari, descritti come
un “nemico interno”, la loro non sembra una paura immotivata.